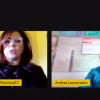Abbiamo conosciuto Paola Suraci in uno dei tanti incontri sulle questioni di genere, sulla giustizia sociale o sulle tematiche dei migranti. Ci siamo incrociate negli stessi ambienti di studio su questi fenomeni, trovando molte “aderenze” di intenti e di visioni. Alla direzione di www.immezcla.it, Suraci è quello che si dice un esempio del nuovo fenomeno del giornalismo impegnato, che supera il limite del racconto per operare anche attraverso la professione il cambiamento sociale e culturale che sta diventando sempre più urgente.
D- Una collega, cresciuta sul campo, con i fatti di cronaca da seguire ma con la vocazione per i casi di giustizia sociale. La creazione, dal nulla, di una testata giornalistica con uno scopo che va oltre la professione…o forse no
Nasco come cronista. Ho sempre avuto la passione per il giornalismo e così appena ultimato il liceo classico, prima ancora di iscrivermi all’Università per studiare Scienze politiche, sono entrata nella redazione del Giornale di Calabria, era il 1988, avevo 18 anni, si scrivevano i pezzi con la mitica Lettera 22, non esisteva internet e la mia città era nel pieno della seconda guerra di ‘ndrangheta scoppiata nel 1985 e che andrà avanti fino al 1991. Era una città, Reggio Calabria, dove i morti ammazzati per strada erano fatto quotidiano e il clima era invivibile, anche il Teatro Cilea era stato chiuso nel 1985 dalla commissione di vigilanza della prefettura per inagibilità e solo dopo quasi diciotto anni di interminabili lavori è stato restituito alla città. Sono cresciuta, dunque, in un contesto aspro dove però si avvertiva l’urgenza del cambiamento, del guardare oltre e il mio essere cronista mi portava a spingermi sempre più in là, sempre nelle “periferie estreme” per raccontare i disagi. Così man mano che passavano gli anni, e ho cambiato testate giornalistiche, fino ad arrivare alla Gazzetta del Sud e alla corrispondenza per il quotidiano nazionale Avvenire, mi sono sempre più specializzata in un giornalismo “sociale”, d’inchiesta, ma che guardasse il punto di vista dell’altro. Questo mi ha spinta ad entrare nelle carceri, per raccontare la vita dentro e poi ho voluto ascoltare i familiari delle vittime di ‘ndrangheta. Quello che cerco di fare è raccontare ascoltando e mettendo insieme i punti di vista diversi, per capire meglio la realtà che è sempre molto complessa.
Mi sono occupata di periferie urbane ed umane lasciandomi sorprendere dalla bellezza. Le brutture sono davanti agli occhi di tutti, ed è facile trovarle e narrarle, ma la bellezza non è sempre visibile ed allora trovarla è come scoprire un tesoro, quando accade è bello condividerla. Penso ai tanti pezzi che ho scritto per la comunità rom, penso agli incontri fatti nelle comunità per tossicodipendenti, o alla casa di reclusione sperimentale di Laureana di Borrello “Luigi Daga” dove i detenuti giovani, firmano un patto di responsabilità lavorando alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria e imparando delle professionalità spendibili sul mercato. Pensata per chi è al primo reato e nei penitenziari comuni rischierebbe di essere reclutato dalla criminalità organizzata.
D – Quale il momento, l’evento, il percorso che ha segnato, nella tua vita, il passaggio dal fare per sé al fare per gli altri?
Non c’è un momento preciso, in verità, è stato un lungo cammino personale e giornalistico. Ho sempre inteso il mestiere di giornalista come un servizio, reso alla comunità, non solo dal punto di vista dei fatti da raccontare, come verità appunto, ma anche come momento di analisi: se scopri l’altro e capisci il contesto hai una visione dei fatti più oggettiva. Ecco che poi il giornalismo può diventare motore del cambiamento, si ha una presa di coscienza e quindi si possono innescare politiche per il miglioramento delle condizioni di vita.
D – lavorando a stretto contatto con il mondo delle migrazioni, le questioni logistiche, pratiche, le vite di ogni singola persona, da una parte e dall’altra dell’accoglienza, cosa secondo te manca, nel mondo della comunicazione generalista, cosa non viene colto e che invece potrebbe aiutare nella comprensione del fenomeno, con i suo pregi e i suoi difetti
Ho iniziato a scrivere di migrazioni negli anni Novanta, quando sulle nostre coste arrivarono i primi curdi, a Badolato a Riace e poi via via anche al porto di Reggio Calabria. La cronaca mi portava a narrare gli sbarchi. Ho avuto le prime pagine di Avvenire e le aperture dei tg nazionali, perché nel frattempo lavoravo per una agenzia video giornalistica. Guardare queste famiglie arrivare stremate, vedere nei loro occhi la disperazione mi ha portato a voler ascoltare le loro voci e così ecco che ho iniziato a raccontare le loro storie. Negli anni ho seguito quanto accadeva in Calabria, prima, e poi in Italia. L’accoglienza e i progetti di integrazione. Sono passati più di vent’anni ormai, dai grandi esodi, senza considerare che già negli anni Ottanta c’era stata una prima ondata migratoria verso il nostro paese. Negli ultimi anni, poi, con il nuovo flusso migratorio e la guerra in Siria abbiamo visto tutti cosa è diventato il Mediterraneo e il lavoro prezioso delle Ong che con le loro navi hanno cercato di salvare vite umane, eppure sulla pelle degli ultimi si sono fatti giochi di potere e politiche orribili. I decreti Salvini sono ancora in vigore e la politica italiana è del tutto inadeguata. Dal 2013 ho fondato il giornale online www.immezcla.it dedicato ai temi delle migrazioni perché ero stanca della narrazione che veniva fatta del fenomeno migratorio in Italia. Le grandi testate, – secondo indagini statistiche condotte ad esempio dalla Fondazione Leone Moressa – hanno continuato a narrare di sbarchi seguendo la logica dei numeri e quando i migranti ottenevo il titolo in prima pagina era solo per fatti di cronaca negativi, così la nazionalità era associata ad un crimine. Una narrazione completamente ostile che porta anche a seminare l’odio. Ecco io volevo e voglio smontare queste logiche: analizzo i fatti, contestualizzo le situazioni e anche i numeri vanno contestualizzati. I migranti, soprattutto, non sono numeri ma sono persone, ed allora se racconti che sono arrivati 500 migranti, ancora, in Calabria susciti spesso rabbia, ma se racconti che Mohammed e sua moglie Fatima hanno rischiato di morire in mare e adesso sono stati accolti in un piccolo paesino calabrese e lì hanno fatto nascere il loro primo figlio, capisci che è diverso e scardini il concetto di “invasione” per far “accogliere l’altro che è uguale a te”. Quello che continua a mancare nella comunicazione generalista è però la comprensione che l’Italia ormai da tempo è multiculturale e le cosiddette “seconde generazioni” che in realtà sono terze o quarte, sono diventate grandi, sono giovani trentenni che sono inseriti nel contesto sociale italiano ma che hanno forte e saldo il legame con le loro tradizioni e le loro origini. Ecco questa consapevolezza ancora in Italia manca tra la gente, ma soprattutto nel mondo della politica che è ferma al dibattito, iniziato nel 2005, sullo ius sanguinis o sullo ius soli, ma non si decide ad approvare la legge sulla cittadinanza. Eppure questi ragazzi, senza o con cittadinanza in tasca, sono italiani, con la pelle nera o con il velo in testa, cattolici o musulmani. Hanno studiato nelle università italiane, hanno bene in testa quella che è la loro condizione e non si sentono a casa, pur essendo a casa loro.
D- qual è l’ambizione di Immezcla e quale quella di Paola Suraci, in che modo volete contribuire a cambiare il mondo?
Con Immezcla sto portando avanti questa battaglia sulla cittadinanza, non solo come atto formale per le seconde generazioni, ma come riconoscimento sostanziale. Credo che un’Italia pienamente interculturale sia una grande risorsa per tutti noi e sia bellissimo viverla. Ma occorre un cambiamento culturale, occorre abbattere la cultura dell’odio che ha radici profonde anche in Italia. La nostra storia di “impero coloniale” ancora non è sta affrontata e anzi si è rimossa con tutti i danni che ha prodotto in Africa. Si badi bene che il colonialismo italiano è nato con lo stato italiano, e non fu certo di minor impatto rispetto agli altri paesi europei, anche se per importanza non raggiunse mai Francia, Gran Bretagna o Germania. La sua costruzione ideologica avvenne per forza di cose tardivamente dato che l’unità nazionale si raggiunse solamente nel 1861. Nel 1882 avvenne così l’acquisizione della baia di Assab, in Eritrea. Poi il Fascismo continuò l’operazione di conquista. Serve, urgentemente, decolonizzare lo sguardo. Analizzare i fatti, capirli e restituire alla storia gli avvenimenti liberandoci però da quel sentire, che è ancora strisciante e presente in Italia. Per farlo bisogna essere insieme: no bianchi contro neri, ma insieme. Ascoltare le “seconde generazioni” e capire il loro malessere sarà utile per costruire una società più giusta.
D – attiva anche nel mondo delle politiche paritarie, non solo delle migranti ma di tutte le donne; come donna e imprenditrice, dal tuo punto di osservazione, cosa ha cambiato la crisi Covid nel dinamiche femminili del lavoro e della vita sociale?
L’emergenza Covid19, oltre alla drammaticità della morte, ci pone di fronte ad un passaggio cruciale, a mio avviso. In questi lunghi mesi, per proteggerci siamo rimasti a casa, isolati ma connessi. Questa connessione, con il mondo della scuola, con il lavoro, con gli amici, se ci ha consentito di superare un momento drammatico, rischia adesso di diventare un boomerang. Mi spiego meglio: lo Stato, le imprese, hanno preso consapevolezza che è possibile lavorare in smart working ma, permettetemi di dire, che non è facile lavorare in smart working per una donna, da casa, con un carico familiare notevole, schiacciato sul lavoro di cura. Se le scuole non dovessero riaprire a settembre, se si dovesse ancora stare a casa per i ragazzi, penso proprio che quelle che pagherebbero il prezzo più alto sarebbero ancora una volte le donne. Il lavoro fuori casa sarebbe a rischio perché ancora “il lavoro delle donne” è prima di tutto quello di reggere responsabilmente un sistema di potere patriarcale che vuole che sia la donna ad avere “il carico mentale” delle relazioni familiari e ciò vuol dire che se qualcuno dovrà restare a casa ad accudire i figli, anche si ci saranno i congedi parentali, in questa Italia, saranno in gran numero le donne.
Badate bene che non sto parlando solo ed esclusivamente del salario, cosa che ovviamente in un periodo di grande crisi economica, è da tenere in considerazione. Sto pensando, più precisamente, a cosa vuol dire tenere le donne “fuori” dalla società, fuori della socialità, fuori dai luoghi di lavoro. Siamo già indietro di molto sulle conquiste delle donne, e non possiamo permetterci adesso di tornare indietro. Dopo settantanni di lotte femministe, dopo che siamo uscite “dalla caverna”, dallo stretto ambito familiare, non possiamo e non dobbiamo tornare dentro.
Raffaella Rinaldis