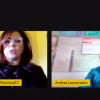Nel labirinto oscuro della violenza di genere, la parola che più pesa — e più manca — è volontà. Quella della vittima, prima di tutto. Perché in Italia, davanti a uno stalker, a un compagno violento o a un persecutore, solo lei può denunciare. Solo la vittima può dare avvio a un procedimento penale per stalking, maltrattamenti o minacce reiterate. È una scelta che la legge (articolo 612-bis del Codice penale, introdotto nel 2009) tutela come diritto di autodeterminazione, ma che diventa spesso un muro invalicabile quando quella volontà è spezzata, manipolata, disinnescata dalla paura.
Ed è qui che la rabbia della madre di Pamela Genini, esplosa pubblicamente in questi giorni, diventa il riflesso di un dolore collettivo. Una madre che cerca risposte, che punta il dito contro le amiche della figlia, chiedendo perché nessuna abbia denunciato, perché nessuna l’abbia salvata. È una reazione umana, comprensibile, persino necessaria per sopravvivere alla perdita. Ma è anche un grido che si scontra con la realtà più amara: le amiche non potevano farlo.
Nell’ordinamento italiano, infatti, lo stalking è un reato “a querela di parte”. Significa che l’azione penale scatta solo se la persona offesa presenta denuncia, salvo pochi casi in cui interviene d’ufficio (come quando la vittima è minore o il fatto è connesso ad altri reati più gravi). In tutti gli altri casi, anche il genitore più attento o l’amica più premurosa non possono sostituirsi alla vittima. Possono segnalare un sospetto, certo, possono rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere consiglio o riferire fatti preoccupanti, ma la denuncia vera e propria — quella che fa scattare il procedimento — deve essere firmata da chi subisce.
E qui si apre il baratro. Perché molte donne non riescono a denunciare non per leggerezza, ma perché vivono in una rete di controllo emotivo e psicologico che paralizza. Il manipolatore sa trasformare l’amore in dipendenza, la paura in vergogna, il dolore in silenzio. Così la vittima smette di percepire il pericolo, difende il suo carnefice, minimizza, spera. E nel frattempo, chi le sta accanto — madre, amiche, sorelle — assiste impotente.
Secondo i dati ISTAT più recenti, circa il 31,5% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Di queste, solo una su quattro ha sporto denuncia. Per lo stalking, la percentuale di chi denuncia è ancora più bassa: meno del 20% delle vittime. In molti casi, le donne raccontano di aver sopportato per anni prima di cercare aiuto, e il 73% di chi contatta il numero antiviolenza 1522 dichiara di non aver mai denunciato. Numeri che raccontano una verità spietata: la paura, il senso di colpa e la manipolazione spesso vincono sulla libertà.
Per questo, la rabbia della madre di Pamela, pur comprensibile, colpisce un bersaglio sbagliato. Le amiche non avevano strumenti legali per agire al posto suo. Potevano starle accanto, parlarle, incoraggiarla, tenderle la mano. E forse l’hanno fatto. Ma non potevano salvarla con una firma che non fosse la sua. La denuncia è un atto di libertà, e la libertà non si impone: si accompagna, si coltiva, si attende.
Nessuna madre dovrebbe trovarsi a chiedersi se le amiche avrebbero potuto fare di più. Nessuna amica dovrebbe portare il peso di una morte che non poteva evitare. In questa spirale, c’è un’unica colpa certa: quella di chi toglie alla donna la possibilità di scegliere, di parlare, di vivere senza paura.
La giustizia può arrivare solo quando la volontà della vittima riesce a emergere dal silenzio. E allora il vero compito di chi sta accanto non è sostituirsi a lei, ma aiutarla a ritrovare quella voce. Perché la denuncia è un gesto di coraggio, ma prima ancora è un atto di consapevolezza. E quella consapevolezza — la più difficile, la più fragile — è ciò che, se conquistata, può davvero salvare una vita.
Deborah Serratore