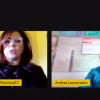Il 25 novembre è il giorno in cui si marcia e si urla il dolore, ma il femminicidio è un problema di ogni giorno e sembra che proprio all’avvicinarsi della data ormai di commemorazione delle vittime, si acuisca il fenomeno o, forse, si diventa più sensibili. Per poi tornare ad elencare le notizie tra i post dei social e la condivisione dell’orrore e della rabbia.
E non accade solo a livello sociale. Le politiche di contrasto infatti, non possono limitarsi a provvedimenti emergenziali come ancora avviene. Richiedono un impegno costante in termini di fondi per i Centri Antiviolenza, formazione specifica per tutti gli operatori coinvolti e, soprattutto, un investimento massiccio e di lungo periodo nell’educazione di genere nelle scuole, per smantellare dalla radice la cultura che considera la donna un possesso. Solo così il 25 novembre smetterà di essere il giorno del lutto e diventerà, finalmente, il giorno della memoria di un orrore superato.
Così, mentre l’Italia si avvicina al 25 novembre, ricordarlo non fa mai male: “La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, un’ombra lugubre e fin troppo familiare torna ad allungarsi sulla cronaca nazionale, l’escalation dei femminicidi. Questa recrudescenza non è un picco casuale, ma la drammatica e ciclica manifestazione di una violenza strutturale che, nonostante gli sforzi normativi, continua a mietere vittime con una regolarità agghiacciante, in particolare nell’ambito familiare e affettivo, cioè il contesto di cura e protezione dal resto del mondo.
I dati ufficiali e quelli elaborati dalle reti di attiviste sono impietosi e disegnano un quadro di emergenza costante. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 10 novembre 2024, il numero delle donne vittime di omicidio volontario si attesta a 97 (un dato che, pur registrando un lieve calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, resta inaccettabilmente alto). Di queste, 83 sono state uccise in ambito familiare/affettivo, con 51 vittime per mano del partner o ex partner.
Ogni singola cifra cela una storia di fallimento delle istituzioni e della società.
Ormai da un po’ di tempo ho avuto modo di relazionarmi direttamente con l’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la Violenza) questa sottolinea, attraverso i dati raccolti dai suoi Centri Antiviolenza (CAV), che la violenza viene esercitata nel 74% dei casi dal partner o ex partner, percentuale che sale all’84% considerando anche gli altri familiari. Questi centri, con 118 sedi e 23.158 donne ascoltate in un anno, rappresentano l’estrema trincea di accoglienza e supporto, operando spesso in condizioni di risorse esigue. La violenza denunciata è pervasiva: fisica, psicologica, sessuale ed economica.
Di fronte a questa carneficina, la risposta politica e normativa non è mancata, ma l’efficacia dei provvedimenti è ancora oggetto di dibattito.
L’intervento normativo più significativo degli ultimi anni è stata la Legge n. 69/2019, il cosiddetto “Codice Rosso”. Questa norma ha introdotto modifiche al codice penale e di procedura penale per accelerare l’azione giudiziaria in caso di violenza domestica e di genere, prevedendo, tra l’altro, termini più brevi per l’inizio delle indagini e l’inasprimento delle pene per reati come maltrattamenti e stalking.
Successivamente, il dibattito si è concentrato sull’introduzione del “delitto di femminicidio” come figura autonoma di reato, come previsto da recenti disegni di legge (Ddl), che mirano a rafforzare ulteriormente le misure di contrasto e la tutela delle vittime. Il percorso legislativo è in evoluzione, ma l’attenzione resta alta sulla sua effettiva capacità di superare le criticità applicative emerse, per esempio, con il Codice Rosso stesso (come i problemi di sovraccarico degli uffici giudiziari e la necessità di una formazione specifica di magistrati e forze dell’ordine). Il solo dibattito sul termine femminicidio (c’è ancora chi si rifiuta di riconoscere questa definizione) indica senza ombra di dubbio come la questione rimanga ancora ferma alla collocazione culturale, prima ancora che operativa e normativa.
Il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (Lx n. 12/2023) monitorano e propongono azioni, riconoscendo l’urgenza di un approccio non solo repressivo ma soprattutto preventivo.
In questo senso si inserisce l’azione di organizzazioni come ActionAid, con il Progetto NORA, che non si limita alla gestione dell’emergenza ma si concentra sulla prevenzione primaria, sullo scardinamento degli stereotipi di genere nelle comunità e sull’empowerment socioeconomico delle donne che escono da percorsi di violenza. L’obiettivo è chiaro: un intervento efficace non può prescindere dall’educazione al rispetto e all’uguaglianza, unica vera arma contro la cultura patriarcale che alimenta la violenza.
L’analisi del fenomeno, supportata anche dai lavori dell’Osservatorio sulla Violenza di Genere e Domestica del Ministero della Giustizia, evidenzia che le riforme legislative rischiano di restare parzialmente inefficaci se non si agisce sul piano culturale. L’aumento del numero di omicidi di donne avvenuti in un contesto relazionale familiare è una cartina di tornasole di una società che fatica a riconoscere e rispettare l’autonomia e l’autodeterminazione femminile.
Come emerge dai rapporti di D.i.Re e ActionAid, i Centri Antiviolenza sono spesso l’ultimo rifugio per donne che hanno subito anche una “vittimizzazione secondaria” all’interno del sistema giudiziario, dove talvolta persistono stereotipi di genere nella valutazione delle prove e delle competenze genitoriali. L’esistenza del fenomeno della violazione dei provvedimenti di allontanamento, che pure è sanzionata, dimostra che la sola norma penale non basta a fermare la volontà omicida, ma necessita di un sistema di protezione e monitoraggio più capillare e risorse adeguate per la tutela.
A questo punto dovremmo capire anche come intervenire nella programmazione delle giornate di commemorazione, dove ogni nome che viene ricordato sottolinea l’inefficacia di un sistema normativo e di intervento che ancora non ha capito in che direzione muoversi o, anche, quanto e come deve investire per invertire la tendenza.
Mi auguro così che il 25 novembre non sia solo una giornata delle donne che raccontano di altre donne uccise, non sia solo una commemorazione ma un momento di confronto fattuale per intervenire anche a livello locale, che sia l’occasione per condividere tutti, uomini in primis, istituzioni con azioni concrete, persone con il cuore e la mente aperti, in attesa di comprendere con chiarezza cosa accade intorno a noi e pronti a capire che siamo tutti, nel nostro piccolo, potenziali “alimentatori” di violenza… ma che possiamo, altrettanto, diventare strumenti di dissolvimento della violenza.
La Direttora
Raffaella Rinaldis